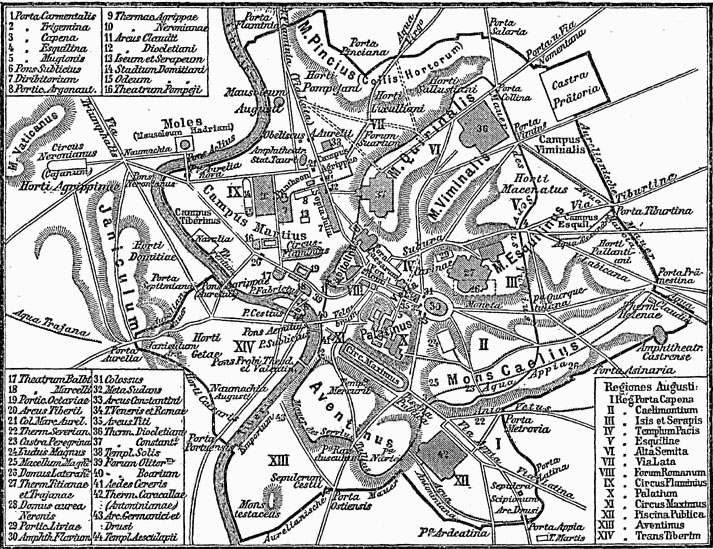Mura di Roma
… Ma mo che viene sera e c’è il tramonto io nun me guardo ‘ndietro… guardo er vento. Quattro ragazzini hanno fatto ‘n’astronave con ‘n po’ de spazzatura vicino ai secchioni, sotto le mura dove dietro nun se vede e c’è ‘n’aria scura scura. Ma guarda te co’ quanta cura se fanno la fantasia de st’avventura… Me mozzico le labbra me cullo che me tremano le gambe de paura poi me fermo e penso: “Però che bella ‘sta bella fregatura…” .
Alessandro Mannarino, Il bar della rabbia
A ventuno anni scrivevo già disillusa, come se avessi alle spalle una vita. E’ che Roma mi si imponeva. Tutti coloro che sono cresciuti a Roma, in un modo o nell’altro la interpretano, ma senza poter lasciar fuori se stessi. La me stessa di allora, incastrata nei sogni ineluttabili della mia età, immaginava poesie impossibili.
“Diario”, 23 febbraio 1991
Sono cresciuta col mito di Roma, non solo perché romana, ma anche e soprattutto per il clima che ho respirato in famiglia fin da bambina.
Fin quando gli occhi vedono solo ad una centimetro di distanza, quella vista circoscritta che si conosce a memoria, è, inevitabilmente, il mondo.
Ma poi, per chissà quale incanto, quella vista si allarga smisuratamente.
Anche se da lontano non si può vedere bene come da vicino, ora si può benissimo intuire tutto ciò che si stende fino all’orizzonte. Ora si sa, e ciò è più importante di non poter ben vedere. Prima non lo si sapeva.
E non vedere completamente non è comunque tutto il male, perché, fin quando nessuno ci parla e ci mostra cosa c’è oltre, esiste l’immaginazione, la fantasia, e di qui, come sempre, l’amore per ciò che è diverso, non familiare, lontano…
Era bello il tempo in cui, molto leopardiana, potevo sognare e creare i miei mondi infiniti, diventare poeta con i pochi indizi di realtà che possedevo.
Creazione è amore, questo l’ho sempre sperimentato; ed è per me l’esperienza più bella. Ma questa cade in fretta, almeno per chi, molto leopardiano, volendo cercare a tutti i costi nuovi indizi di realtà (anche per giocare con la stessa invenzione), comprende che alla fine quelli portano ad un quadro che assomiglia sempre di più al vero e che la favola è oramai scomparsa.
Il quadro che mi si presentò innanzi era così orribile che non ho più potuto dimenticare quella immagine.
Di questo quadro, naturalmente, del luogo dove sono nata e vivo (e per induzione, di tutto il mondo ad esso vicino) e nel luogo dove sono nata e vivo, quasi nessuno sa.
Non sapere, qui, significa non conoscere quei “pittori”, non conoscere, cioè, io credo, quella specie di colore marcito, mescolato ai colori, con cui si dipinge lo scenario di questo nostro mondo nel quale viviamo e ci muoviamo con tanta apparente disinvoltura.
Ma non sapere vuol dire essere soddisfatti, sempre, e non dare dunque noia a chi ha disposto così (male) della nostra vita.
Non è difficile mantenere questa diffusa non conoscenza. Il mezzo migliore è senz’altro creare i miti.
La parola, logicamente, non è intesa nel suo senso classico, poiché il mito classico è spontaneo e nasce, in quanto tale, dall’ingenuità. Il mito moderno-occidentale, invece, è costruito a bella posta dall’alto, è un bisogno indotto.
Roma/mito è il luogo di rifugio/rifiuto nel quale qui, in Italia, ad esempio, si ha bisogno di imbattersi per aver coscienza di sé. E’ segno dell’esserci dell’Occidente.
Il porsi come realtà concreta, presente in ogni momento e in ogni spazio, è l’antidoto principale al sentore di vuoto, di non-realtà che pervade inevitabilmente ciò che è artefatto, falso.
Parlo di Occidente e non solo di Italia perché Roma è sempre presente, non solo per ciò che riguarda la dimensione temporale, ma anche quella spaziale (in quello spazio che è tutto lo spazio, il mondo nord-occidentale).
Roma, città inefficiente, sporca, caotica, è pretesto per il giudizio negativo, per l’autocritica, anche, per l’esame di coscienza. E’ quindi pretesto per parlare di sé, mentre l’altro è lasciato in secondo piano.
E’ nello stesso tempo, di per sé, la città che impone uno stile, simbolo della civiltà, della cultura, dell’antichità civile e colta, dell’antica gloria, dell’antico potere. La Roma Caput mundi si congiunge a sua volta con la madre del cattolicesimo, vale a dire dell’universalità.
Si tratta di prerogative totalizzanti, che estendono la loro potenza ovunque, non solo nel nord-ovest del mondo. Anche in Africa, nell’America meridionale, in Asia si conosce tutto del nostro modus culturale, della nostra storia. Gli intellettuali del Maghreb, ad esempio, sanno tutto di noi, sanno di Roma, delle altre città d’arte; sanno anche del calcio, dei personaggi dello spettacolo, della cultura di cartapesta. Noi di loro non sappiamo nulla.
Questa città è la nostra città d’esportazione, souvenir/simbolo del ricordo/presenza per tutti. Soprattutto per quel mondo di cui non avvertiamo neanche l’esistenza e che sembra servire solo ad importare sottocultura, ad imparare, ad imitare, ad essere, in una parola, per necessità, inferiore. Ecco quello che con profonda tristezza ha ammesso questo cuore perso per il luogo d’origine, per il luogo mitico.
Ecco cosa ha provocato la vergogna che a volte mi assale quando incontro un immigrato che abita, per campare, in questo paese, dove l’opulenza convive con la miseria come se ciò fosse più che normale.
Ma guardo ancora a come questa città potrebbe essere. Penso ad un futuro nel quale potremmo diventare in molti a renderci conto che gli scarti che questa città sta lasciando dietro di sé sono la sua vera ricchezza.
La bellezza di Roma potrebbe non voler essere più solo esteriore: negli occhi di molti potrebbe divenire l’immagine di uno spirito nuovo, aperto al mondo intero, a quello vero, ma anche al nostro, per vederne le contraddizioni e per colmare questo vuoto che è la stupida paura del diverso, dell’inconsueto.
Ecco, io, che non so quasi niente di coloro che abitano nel Sud del mondo, vorrei che conoscessero gli sforzi e la speranza di molti di noi.