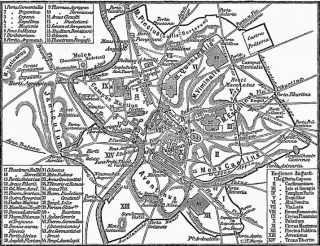Mario Mafai, Demolizioni
Ho trascritto la pagina del mio “diario” datata 8 dicembre 1990.
A quei tempi nei sotterranei della stazione Termini che portano alla metropolitana non c’era il centro commerciale che c’è oggi, in continuità con la serie di negozi che si trovano al livello della superficie stradale. L’immenso androne sotterraneo era completamente vuoto e molto sporco. Si riunivano lì ogni giorno, se ricordo bene nelle ore serali – immaginavo dopo una giornata di fatica, per lavoro od occupazioni che quello avrebbero il più possibile voluto imitare – uomini africani subsahariani. Erano neri, alti, magri, giovani, tanti. Lì trascorrevano il tempo discorrendo tranquillamente tra loro. Io passavo ogni giorno per quel luogo per andare e tornare dall’università. Tutti noi utenti della metro passavamo di lì. Non ho mai provato la benché minima “paura”. Era comunque un passaggio obbligato per raggiungere la metro e quindi l’andirivieni di gente comune era incessante.
Odio la retorica e dovrei starmene zitta per non sentirne l’odore. Ma non lo sento per nulla in quell’affanno, lo stesso che potrebbe sembrare, invece, proprio il segnale inequivocabile di una certa retorica, a non tenere conto che lo esprimeva una giovane ragazza (avevo ventun anni) che non riusciva proprio a starsene zitta, seppure soltanto sopra le pagine di una specie di diario.
***
La gente riempiva la stazione. Sentiva freddo. La stazione era diversa dalle altre sere. Era molto affollata: alle cinque è più affollata che alle sette, e quella sera erano ancora le cinque.
Chissà perché ogni anno, sotto Natale, lì c’è meno luce che nei soliti giorni.
Quando entri nella stazione e scendi le scale, trovi uno spiazzo che si ramifica nelle strade che vanno alla metropolitana. Quella lì sotto sembra praticamente una “piazza”. Non è la piazza di una città o di un paese o di un quartiere. E’ la “piazza” di un posto chiamato Nulla. C’è solo quella, il resto è invisibile; il resto, più che altro, è estraneo.
Fa freddo, eppure è una “piazza” chiusa e piena zeppa di gente, di fiati, di fumo…
Esistono le case e le famiglie e poi le piazze. I giornali e la televisione le chiamano “luoghi di aggregazione”. Sono luoghi in cui casa e famiglia si fanno enormi, immense, e scoprono di che pasta sono fatte, a quale mondo, ancora più grande, appartengono.
Dietro una piazza c’è sempre qualcosa, altrimenti quella piazza sarebbe un non senso. Dentro una piazza c’è chi viene, mai chi sta, per starci sempre, e basta. Altrimenti non sarebbe un posto da frequentare, ma un luogo-rifugio. Il luogo-rifugio dall’aspetto della piazza (perché pieno di gente) per eccellenza è il ghetto.
E chi siamo noi, invece, noi che apparteniamo a ciò che è al di fuori del ghetto? Noi italiani, noi romani, noi che ci serviamo della metro apparteniamo forse a qualcosa che non sia un semplice nulla?
Il Nulla esterno ogni tanto passa per il ghetto, vi entra e squarcia la materia col suo non esserci; poi, quando è uscito, la ferita si rimargina.
Traiettorie infinite che si sovrappongono sono queste suture. Oltre a quelle, restano loro. Mentre di fuori rimane quel Nulla, che era stato lì, solo di passaggio.
Tutte le sere di lì io passo per andare a prendere la metropolitana. Passo e guardo. Vorrei che il ghetto non si squarciasse nel segmento che le mie gambe seguono. Vorrei addirittura fermarmi.
Sotto Natale, lo squallore di questa “piazza” di un posto chiamato Nulla mi sembra moltiplicato. Ci sono persone più derelitte che mai. Una vecchina… come faccio a dimenticare? Ma se la serenità sta solo nell’oblio?… era sepolta dal putridume, curva, il viso reclinato, coi capelli lunghi, neri di sporco, che parevano finti, di paglia, e le cadevano giù, davanti al viso e al petto. Per un po’ anche il resto del ghetto mi lasciò indifferente di fronte ad un essere che ormai suscitava più ribrezzo che pietà, o solo quello. Se quella vecchia era lì, viveva in quella “piazza”, anche lei era, anzi, più di tutti, scarto del non esserci. Anche io lo ero, per pochi istanti, mentre passavo. Dov’era la città? Mi chiedevo. Roma non c’entrava nulla. Roma non c’era. Non esisteva.
Roma non esiste per gli immigrati che hanno trovato il loro rifugio nei sotterranei della stazione: non può certo dare loro alcunché, tranne che permettere, senza far nulla, così, naturalmente, che si creasse un misero luogo dove poter stare. O con accondiscendenza Roma ha procurato loro il ghetto, il misero luogo, di scarto, perché già da anni è servito solo come dimora per quelle povere vecchie, deformate mostruosamente da ogni mancanza di visibile dignità. E da anni serve solo da passaggio ai normali cittadini che vanno e vengono dalla stazione, i normali cittadini che sanno chiudere molto bene gli occhi…
Passavo e sentivo freddo. Io romana? Cittadina di questa città? Cittadina del Nulla. Dormitori, luoghi dove si lavora e luoghi dove si cerca di essere, inutilmente: ecco la città, ecco il Nulla.
E le piazze vere, quelle all’aperto? Nei quartieri non centrali o sono vuote o non ci sono. Al centro si riempiono nel fine settimana. Ma sono appannaggio dei turisti e restano ugualmente piazze di una città che non c’è. Lì, più che altro, i cittadini di una città inesistente tentano di essere cittadini e si illudono di essere romani. Ma non possono. E’ il loro momentaneo “rifugio”, quello sì davvero alienante, molto più del rifugio-stazione. I cittadini del Nulla sono, infatti, necessariamente invisibili. Quando vanno nelle piazze vere, nelle piazze esterne, non si vedono tra loro. Sono completamente estranei l’uno all’altro.
Nel sotterraneo della stazione, prima di imboccare il percorso diretto alla metro che dovevo prendere, stavo quasi per sorridere, se non avessi poi fatto altro: al ghetto tutti si conoscono, si conoscono bene. Parlano tra loro per un po’ di tempo, tranquilli, umili.
Forse hanno tentato al principio, i ragazzi del rifugio-stazione, o forse no, di vivere nella città-fantasma che riesce ugualmente così bene, nella sua inconsistenza, ad esprimere il proprio astio, nella città che possiede ancora tutta l’energia per mostrarsi ostile a chi davvero l’avrebbe fatta tornare ad una qualche vita. Ma Roma non vuole sapere, non vuole conoscere, non ha alcuna curiosità per il reale, non vuole vivere, odia la vita. E quelli del ghetto, i diversi, gli stranieri, i nuovi si sono messi da parte, si sono esclusi proprio per quello, per difendersi da quella morte, da quel nulla. Per vivere.
Avrei voluto essere lì, tra gli immigrati africani, mostrare loro che capivo la grazia di quel coraggio, ma si ostinavano a non accorgersi di me. Mi sono tenuta le lacrime della mia commozione per me, mentre me ne andavo, senza illudermi che avessero almeno intravisto una semplice ragazza, indecisa se sorridere o no, fatta come loro.