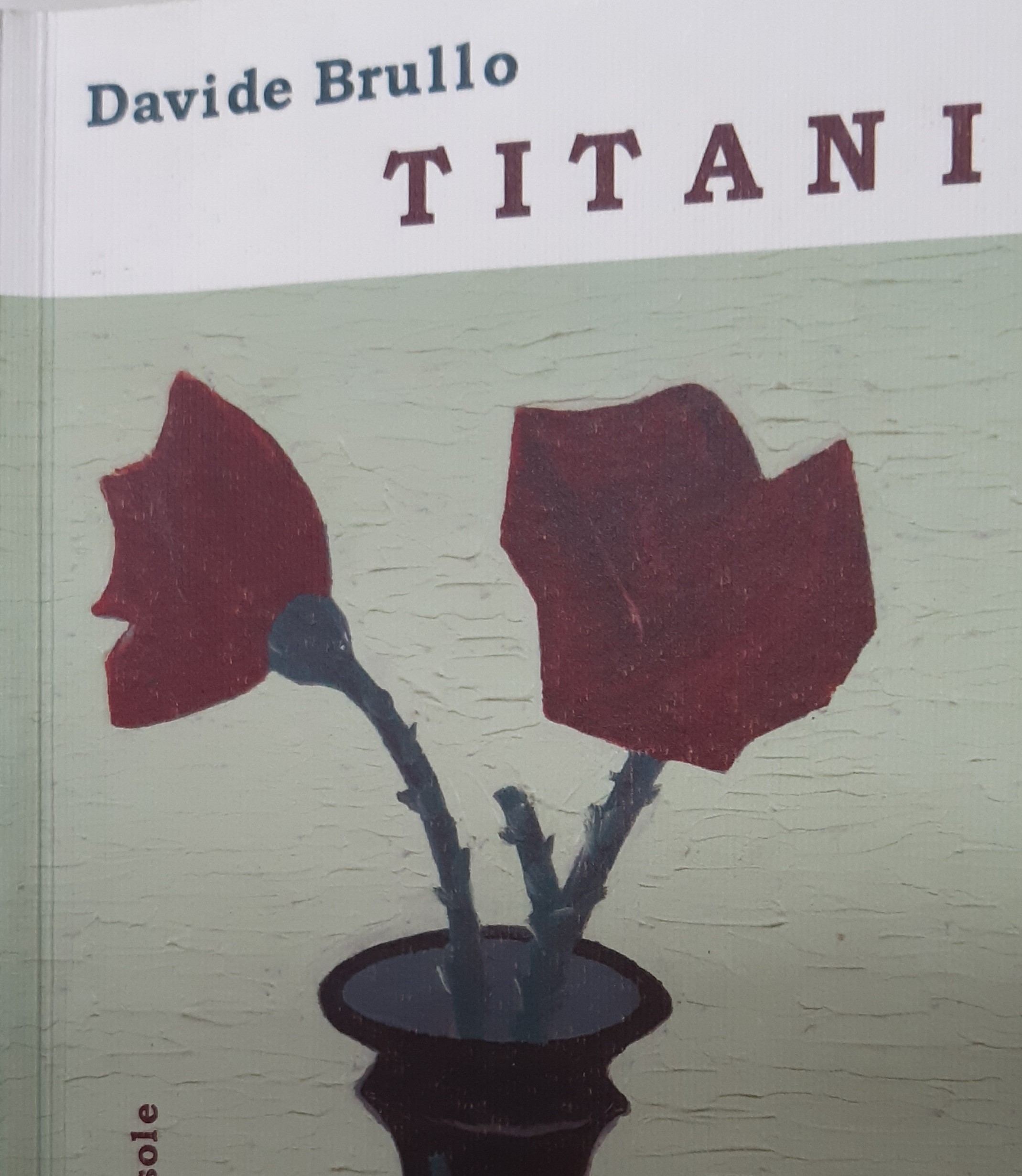Davide Brullo ha spesso criticato, in modo pungente, divertente, intelligente, libri pessimi ma apprezzati, se non addirittura osannati (tipo Ferrante e Giordano), dalla critica incompetente ma maggioritaria, e lo ha fatto prima su Linkiesta.it e poi su Pangea.news . Ne ho condiviso spesso il tono corrosivo, spesso anche l’argomentazione, la spina dorsale di una recensione degna di questo nome.
È insomma, secondo me, molto bravo a fare critica letteraria, ha davvero l’acume giusto. Questo è il motivo per cui, quando lo lessi le prime volte, mi chiesi subito come facesse letteratura lui stesso e quindi comprai due suoi libri. Mi spingevo ad aspettarmi meraviglie. Ho iniziato a leggere Titani (solo le prime quattordici pagine) giusto per farmi un’idea, rimandando la lettura vera e propria a tempi più adatti allo scopo.
Questa quindi non è una recensione, scaturisce da qualche appunto fatto a margine di queste pagine.
Il libro è aperto da un breve testo, Testamento, una sorta di prologo al testo narrativo (così come l’editore lo definisce). È perfetto. Troviamo metafore la cui eleganza è fuori di ogni dubbio: ci è vietato sospettare che dietro si nasconda della furbizia. Il brano non è lungo, non arriva alla pagina e mezza, è calibrato, ha il ritmo e la struttura delle immagini a definirlo come si deve. Una bella pagina, insomma, in cui le metafore e le similitudini iniziano a suggerire, come infatti devono fare. La microstoria narrata è strana, delicata, perfetta, appunto.
Davide Brullo è, sì, molto bravo, ma il problema, in questi casi, è restarlo per tutto un libro di centosessanta pagine, di cui non so nulla, è vero, ma di cui le ulteriori dodici pagine (che formano una sorta di introduzione ad un successivo ‘diario’) danno senz’altro un’idea. E qual è l’idea? La solita, purtroppo, in questi casi. È l’impressione che sia emerso il farsi prendere la mano da quel talento che toglie il talento. Fatto gravissimo, anche se la scrittura sciatta, e che non recupera con un minimo di grandezza della storia, è forse peggio ancora (vedi la stessa critica di Brullo ad Elena Ferrante). Restare “singolari nello stile” e possedere una “personalità della scrittura”, come recita la presentazione offertaci dall’editore della collana che ospita il libro, senza essere Gadda o Manganelli o, per citare qualcuno di ora, Matteucci, significa, purtroppo, spesso, immolarsi all’immaginazione di un lettore che sospetta il solito autore giovane e ispirato, curvo sul tavolino a cercare come un forsennato il bell’effetto. L’antitesi della letteratura, per miei gusti. Lo so bene che un conto è criticare e un conto è mettersi a fare, e proprio per questo io sono molto interessata alla critica, che invece parecchi detestano. È già un fondamentale passo avanti per la letteratura di ora che esista almeno qualcuno che sappia dare dei giudizi, o almeno ci provi, vista la fortuna della mediocrità di ciò che esce. Poco importa, poi, se chi critica, lo fa col cliché del ‘bastone’. La rubrica di linkiesta.it, sulla quale scriveva Brullo, a parte il merito di avvalersi programmaticamente dell’uso del bastone, lasciava sempre speculare spazio anche all’elogio di una seconda opera. Ho scoperto belle cose grazie a questo contrappunto.
Insomma, con la terza pagina, Brullo, dicevo, comincia a cedere.
Prima frase, primo sbandamento di chi vuole ‘fare quello bravo’: “Mi chiamo Samuele, mio padre si chiamava Davide, mia sorella è Ester – per anni ho amato una bambina di nome Costanza, che non dimenticherò neppure nelle pianure della morte”. Premetto che subito dopo si parlerà di tutt’altro, questo è solo un cenno. Ed il concetto che esprime è comune: ho amato una bambina che non dimenticherò neppure da morto. Forse è un concetto che poteva essere omesso, non rende il brano narrativamente importante, anzi lo allunga inutilmente togliendo forza alla presentazione dell’io narrante, del suo nome e dei suoi famigliari. Capisco che più avanti questa Costanza riapparirà con un proprio ruolo pare decisivo, e dunque un riferimento a lei da subito poteva essere giustificato da questo, ma senz’altro presentare Costanza successivamente, ex abrupto, senza intaccare l’espressione scelta da Brullo in quel punto (“Quel giorno avevamo invitato a casa nostra la mia amica Costanza”), insomma, nominarla lì per la prima volta avrebbe dato un senso di curiosità e di sorpresa all’abbrivio piuttosto scialbo di quella sequenza narrativa.
Ma quel che più infastidisce dell’espressione che apre il romanzo, dopo Testamento, è quell’immagine falsamente colta delle “pianure della morte”. Dico ‘falsamente’ perché il riferimento alla classicità è riconoscibile da chiunque ne abbia un minimo di dimestichezza, ma nello stesso tempo è ‘aggiunto’, esterno, per nulla funzionale al discorso letterario. Indicativamente, la metafora (ma in generale la figura retorica), per divenire esteticamente notevole, deve essere in grado di dare essa stessa nerbo e indirizzo al discorso letterario, il suo apporto geniale sta nel rendere intrinseca alla struttura la sua preziosità. Fuori da questo potere, la ricercatezza, anche la più raffinata (cosa che qui purtroppo non è) risulta comunque costruita e fuori luogo. Il prezzo è altissimo: basta niente per scendere nel ridicolo.
Esempio dalle pagine precedenti, l’incipit, molto bello, di Testamento e di tutto il libro: “Una farfalla cade dal soffitto, rotea, è bianca – forse è un pezzo di intonaco. La farfalla bianca si posa sulla mano del bambino, lui la tocca e la farfalla s’incrina e si spalanca, come una lastra di ghiaccio, oppure come il petalo di un fiore secco, indurito dalla morte, bronzeo”.
Gli aggettivi iniziali formano l’immagine, le si aggiunge subito un senso di mistero. Finisce la prima frase, l’atmosfera fiabesca è stabilita. Compare il bambino, quindi, attraverso la delicatezza di un gesto che è tutt’uno con la dimensione iniziale del brano. Il gesto ne genera altri in una particella narrativa incantevole, in cui una “farfalla che s’incrina” è figura al limite della metafora in un disegno del tutto consono all’andamento precedente. Ecco che viene introdotta la prima delle tante similitudini di cui Brullo fa uso (qui sono due, una dopo l’altra).
L’uso smodato di similitudini, scelto da molti che vorrebbero essere scrittori, è non dico molto pericoloso, ma decisamente fallimentare, perché rivela impietosamente tutta la meschinità del giochino creativo. Lui, invece, ne fa in queste due pagine un utilizzo abbondante, senza scadere però nel delirio di chi crede di aver trovato la formuletta, e quindi si mantiene decisamente abile. La farfalla è qui protagonista della scena, siamo inchiodati a questa farfalla che forse farfalla non è, alla visione magica di un piccolo bambino cui presto si accompagnerà quella di una bimba ancora più piccola di lui, che “serra la bocca simile ad uno scarabeo”. Tutto il momento narrativo è incentrato su una specie di incantesimo, i cui protagonisti sono due bambini: aggettivi (splendidi quelli attribuiti al fiore secco della seconda similitudine), parole e figure sono un tutt’uno con questo incantamento, lo animano, gli danno letteralmente vita.
Questo vuol dire saper utilizzare le figure retoriche di significato.
Ma ritorno al brano che stavo commentando. L’io narrante dunque sta introducendo la figura dei suoi genitori (in particolare quella del padre) in relazione al proprio nome. Il discorso si fa lungo perché – significativamente – colui che parla non si limita ad esaminarne l’etimo ma ne racconta in qualche modo il mito, così come farà poco oltre col nome della sorella. Ma il discorso è anche sfilacciato da continui salti che ne indeboliscono l’efficacia. Il protagonista racconta che la sua nascita rappresentò una sorpresa nella vita dei genitori, ma siccome il padre amava i paradossi lo ha chiamato Samuele, che significa “esaudito da Dio”. Questo riferimento avrebbe potuto consistere in una buona occasione di sviluppo narrativo: dopo aver stimolato infatti l’interesse del lettore per mezzo di un concetto appena esposto, è buona cosa mantenere la tensione dando un senso al discorso; non deve risultare una cosa messa lì così, senza che ne sia chiaro un significato profondo che deve pure starvi dietro. Il bello di questi riferimenti colti sta proprio nel poterli indirizzare verso quel ‘quotidiano’, quel ‘comune’ che si vuole raccontare (anche per opporvisi, volendo), nel poterli cioè mettere in relazione con la porzione di ‘sfera di identificazione’ che si crea tra chi legge e la pagina letteraria. Ma mi pare che la preoccupazione retorica abbia offuscato il giusto indirizzo narrativo e abbia così finito per rigettare l’opportunità che si era presentata a portata di mano. Intanto viene detto, infatti, che, poiché il padre del protagonista si chiamava Davide e amava anche le profezie, e poiché il Samuele biblico fu colui che aveva determinato (il termine è del testo) il re d’Israele Davide, il protagonista può affermare di avere accompagnato suo padre alla morte. Detto così non è molto chiaro. Sarebbe stata necessaria una struttura diversa della sequenza, più ampia, per consentire al lettore di capire meglio il tutto; ma, soprattutto, il nodo della questione sta nel trovare una soluzione che consenta di creare l’attesa di chi legge proprio in base a quello sviluppo, di amplificarla tramite un qualche ulteriore riferimento alla morte del padre. A dire il vero un riferimento c’è, ma non è molto comprensibile, sembra un’immagine a sé stante che nel suo risultare con ogni evidenza niente di più che un’appendice, non solo, anziché suscitare tensione la allenta, ma inoltre infastidisce per la sua ricercatezza. Guarda caso è infatti una metafora cui si legano due similitudini: “[…] io posso dire di avere accompagnato mio padre nella morte – è come un giorno di disgelo, in cui le rocce si sfoderano della crosta grigia come spade, o sogni.”. La cosa peggiore della grossolana presenza di questa frase furba e ‘voluta’ è quella sorta di nonsense creato alla fine, con quel banalissimo “sogno”. Evitiamo di utilizzare la parola ‘sogno’ in tutto ciò che ci piace risulti evocativo, se non vogliamo far sorridere coloro che hanno letto centinaia di volte di questi sogni che non c’entrano molto, o per nulla, o in modo non chiaro, con ciò che si sta dicendo. Ma cosa si stava dicendo? Se è la morte di un padre (ed è la morte di un padre) e se si vuole renderla centrale dell’intero romanzo (credo sia così), dunque è necessario che questa morte risulti da subito potente. Come fare? Non lo so. Ma so cosa non si dovrebbe fare: la prima cosa sarebbe evitare che il lettore smascheri o sospetti soltanto un bel gioco di parole vicino all’idea di ‘morte’ (centrale nel passo).
Dopo questa fastidiosa caduta, oltretutto, non si recupera tornando all’io narrante, al proprio nome, al proprio rapporto con il padre e alla sua morte. No, il brano accosta tante cosette una vicina all’altra che vorrebbero essere ‘speciali’ e raffinate ma che, slegate, abbozzate e timide, non tentano neppure, ripeto, un discorso solido, vigoroso, letterariamente, quindi, ‘bello’. Di queste cosette ne sfarina dunque un’ultima sul nome della sorella, questa volta, in una sequenza che ancora provoca solo la legittima domanda: ma che c’entra? E quel padre, che fine ha fatto, chi è quest’uomo che ama profezie ed etimologie? Cosa è questo sentore di morte che abbiamo soltanto lontanissimamente annusato, e cosa è questo inizio di figlio, questo Samuele ancora in nuce nella sua esperienza della morte?
La sorella si chiama Ester, ma la madre la vuole chiamare anche Adassa per un motivo che sta in una spiegazione né sufficientemente corta per essere accettata come una leggera divagazione né sufficientemente lunga perché abbia un suo respiro, un senso. Insomma, se ne è andata via la prima pagina e sono stati nominati cinque personaggi di cui non abbiamo alcuna curiosità perché anziché ammassare materia per iniziare la consistenza di cui si ha bisogno, si è ammassata retorica.
Ad ogni modo la sequenza sul doppio nome di Ester non rinuncia ad un’altra espressione ambiziosa ma che viceversa risulta troppo facile: “Adassa è il prato in fiore custodito lungo l’infinito inverno dal ghiacciaio”. Già l’idea di custodire un nome fatto prato è sufficientemente allusiva; è d’obbligo lasciarla leggera perché risuoni piacevolmente in chi legge, invece viene appesantita da quella patina da dilettante, recata dall’inutile, goffo aggettivo “infinito”.
Periodi alquanto maldestri si ritrovano, a seguire, piuttosto spesso, come questo, peraltro preceduto da una frase riuscita (ma mi pare che il principale difetto di Brullo consista proprio in questo dire cose belle per poi rovinare tutto dicendo troppo): “Poi li distruggevo [i pezzi di intonaco] – simile al fautore che può nullificare con un battito di ciglia migliaia di elaborate esistenze.”.
Mi immagino Brullo che scrive, tutto affannato a cercare nella sua ispirazione o sui vocabolari (la sostanza non cambia affatto) parole o espressioni rare, singolari – di per sé o rispetto al contesto – come “fautore” (particolarmente infelice), “nullificare”, “elaborate esistenze”. Anche questa frase è molto elaborata: il problema è che si vede. Voler essere ricercati non è esserlo: è abbastanza chiaro, finalmente, ciò che voglio dire?
Comunque, Brullo, continua, giù per questo pendio, ormai velocemente avviato ad abbondare con aggettivazioni, espressioni che ‘fanno strano’, immagini e similitudini ardite; insomma tutto sempre d’effetto, il cui ridicolo si esalta con l’alternarsi alla perfetta banalità di concetti da filosofia prêt-à-porter come questo: “Già allora consideravo la felicità una meta meschina, propria di uomini privi di immaginazione, spogli di grandezza”, o come questo: “La mamma coltivava delle splendide piante – mio padre viveva secondo i valori della provvisorietà e dell’incertezza: contemplava le cose, senza curarsene, ogni creatura ha impressa in sé la morte, diceva, ridendo.”.
E io lettrice continuo a non sapere davvero nulla di queste cinque figure non ‘reali’ nella mia immaginazione ma accennate fuori di me attraverso un affastellarsi di cose inutili, pezzi di immagini, di frasi, di termini, di suoni, tutto fatto a pezzi ed insignificante, a ricoprire, estraneo, il vuoto. Il padre ride e a me non interessa che rida, poi prende un cartone giallo e ci scrive una frase, ma non mi emoziona questo gesto, mi lascia talmente indifferente che alla quarta sillaba successiva già me ne sono dimenticata. Anche perché, al solito, l’autore si mette a parlare di altro. E che cosa dice il padre di così interessante sul cartone giallo? Ci scrive una frase lunghissima e ‘poetica’ , della poeticità stucchevole di chi vuole essere poetico. Ma il volerla, una cosa, la rende soltanto melensa: “Oggi è il giorno in cui cadono le foglie, tutte insieme, come uccelli che falliscono la rotta della propria migrazione – come una donna che rovescia la scatola dei suoi gioielli. Da ieri il mondo ha deciso di finire.”.
Finalmente, subito dopo, è rinominata Costanza, quella che già al quarto rigo era colei che non sarebbe stata dimenticata neanche nelle pianure della morte, e invece noi l’avevamo dimenticata all’istante. Riappare questa ragazza (bambina? Non ricordo…) in un contesto – mi scuso per la durezza – insulso, in cui si precisa che lei era andata a casa di questa famiglia perché il padre aveva insistito tanto e che era bella e “faceva di tutto per accontentare i capricci” del protagonista. Insomma, si continua a procedere per affermazioni superficiali e slegate, per cui non fai in tempo a cercare interesse per un particolare, un gesto, una descrizione, che si passa ad un’altra inezia.
Il problema di questo tessuto narrativo è che la sua spina dorsale, infatti, è fatta di elementi privi di alcuno spessore, e, non possedendo la benché minima forza, tenta di essere sorretta da tutte quelle minuzie esteriori che ambiscono a risultare suggestive e di cui ho lungamente parlato. Sospetto, però, che l’intento dello scrittore non sia stato quello di prendere una situazione narrativa priva di carattere e di conferirle un valore circondandola di frasi ad effetto, ma viceversa di cercare ad ogni costo frasi ad effetto per poi farle stare insieme attraverso una situazione narrativa messa su alla bell’e meglio.
Quando finalmente, subito dopo, per qualche riga, c’è un poco di forza nella storia che si cerca di intessere (si nomina una donna amata dal padre – sorella di Costanza – e si racconta che la madre per questo se ne era andata), ciò perde immediatamente di vigore, perché le si accostano addosso montagne di altre cose e cioè le solite immagini ‘strane’ o ‘poetiche’, e ancora, poi, tutto un discorso ampio (finalmente qualcosa di ampio! Ma purtroppo impiegato per costruire il ragionamento forse più dozzinale di queste pagine…) sull’amarezza dell’essere sopravvissuti, ma non ad una catastrofe (non ne siamo degni), ma a qualcosa di brutto che si è “mangiato l’uomo” e lo ha “corrotto”, lo ha “sostituito”, per cui l’uomo ha un'”abile forma” (sì, “abile”!), ma il suo cuore è ormai orribile, come un “termitaio”. Sono sconcertata: ma cosa sto facendo? Vale la pena di leggere ‘sta roba e commentarla sul mio blog? Eppure vi assicuro che avevo intravisto del talento in questo autore, e che l’intenzione, un domani, di non fermarmi alla quattordicesima pagina era convinta…
Ad ogni modo Brullo continua a procedere così: la storia comincia a delinearsi, affogando però al solito nel suo mare di costruito, di voluto, con tutte le sue similitudini-orpello, noiosissime, d’effetto, giustapposte.
Sono ripetitiva. Ma per fortuna siamo quasi alla fine di questo gruppo di pagine che ho definito come ‘introduzione’. Escludendo tre, quattro righe alla fine, che cadono nel solito difetto, abbiamo, però, all’incirca un’intera pagina finalmente di nuovo bella come Testamento. Perché è bella? Presto detto: perché è compatta, tutto è al posto giusto, le cose dette, i gesti hanno il loro respiro, perché dice qualcosa per tutta la sua interezza, e quel qualcosa, tra l’altro, ha nerbo. Si tratta della malattia del padre. Leggiamo questo passo: “Mio padre era molto magro: la malattia lo aveva ridotto a una falce, il corpo era il lungo manico di legno, il naso la lama – mentre i suoi ricordi, gli uomini che aveva conosciuto e amato [senza virgola, qui, nel testo] costituivano il campo di grano che meticolosamente segava, riduceva a un deserto di piante monche. Mio padre faticava perfino a camminare, non conosceva l’origine e la natura della sua malattia, ma diceva: la tigre bianca [questo è il soprannome della donna che amava] è penetrata dentro di me, e fa razzia delle ossa, come fossero arbusti di carta.
Nonostante la malattia che lo distruggeva giorno dopo giorno, il papà ci obbligava a dormire con lui – e a giocare durante le ore di luce sul suo letto. Forse desiderava che ci ammalassimo anche io e mia sorella, che morissimo con lui. O forse riteneva che la crescita si ottiene attraversando la malattia – ci forniva l’antidoto per varcare il male.
Le sole volte che il papà si alzava dal letto era per preparare il biberon a mia sorella. Scaldava l’infuso di finocchio, che versava dentro la piccola bottiglia di plastica. Addolciva la bevanda con una sfera di miele, bella come la guancia di un angelo. Tornava al letto con il biberon giallo tra le mani, che sembrava una lanterna, e mio padre il creatore del fuoco.”.
Quest’ultimo capoverso è stupendo e possiamo senza turbamenti immaginare che mentre il suo l’autore lo scriveva, gli scivolavano via le parole dalla penna o dai tasti, in stato di grazia.
Cioè a dire che, se vuoi davvero esprimere qualcosa, e hai quel quid per riuscire a farlo bene, evidentemente, la bellezza della frase ti viene di conseguenza. Se ti spremi le meningi per trovare la bellezza e perdi di vista ciò che vuoi dire (sperando che ci sia), il tuo ipotetico talento è già gettato alle ortiche del ridicolo.
E tutto il mio articolo per dire alla fine che senz’altro è molto più facile criticare un brutto libro che cercare di scriverne uno decente. E questo lo ricordo soprattutto a me stessa.